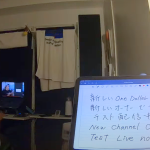Non servono statistiche per accorgersene: basta una passeggiata lungo le strade periferiche di qualunque città italiana per incontrare cumuli di rifiuti abbandonati. Pneumatici scaricati nei campi, frigoriferi a cielo aperto, sacchi di immondizia sulle rive dei fiumi. Il World Cleanup Day 2025, che dal 20 al 28 settembre mobiliterà milioni di persone in 190 Paesi e che in Italia prenderà il via il 20 e 21 settembre da Napoli, intercetta proprio questa ferita quotidiana. Non è un’iniziativa folcloristica di volontari in guanti gialli: è la fotografia di un’emergenza strutturale che le istituzioni spesso faticano a governare.
In Campania, la parola “discarica abusiva” non è mai uscita dall’agenda pubblica, ma lo stesso vale per il Lazio, per la Lombardia, per la Sicilia. Secondo Ispra, il 30% dei rifiuti speciali in Italia non ha ancora tracciabilità certa. Questo significa una filiera grigia, fatta di sversamenti e smaltimenti illegali che inquinano suolo e falde.
Il paradosso è che l’Italia non manca di competenze né di impianti: negli ultimi dieci anni la raccolta differenziata è cresciuta, così come il riciclo. Ma resta un cortocircuito tra innovazione e gestione territoriale. Le aree metropolitane faticano a reggere l’urto dei consumi, e spesso i cittadini si trovano davanti cassonetti traboccanti. Il risultato è la disillusione, la sensazione che la raccolta differenziata non serva a nulla. È qui che il World Cleanup Day ha una funzione non secondaria: rimettere in moto la partecipazione civica, ricordando che il problema non può essere scaricato solo sui “soliti noti”. L’abbandono dei rifiuti è il gesto di singoli, ma la risposta deve essere collettiva.
La discarica nascosta negli armadi europei
Quest’anno l’edizione italiana ha scelto di affiancare la pulizia dei territori a una campagna contro lo spreco tessile. È una scelta tutt’altro che estetica: il tessile è uno dei settori più inquinanti al mondo e spesso escluso dal dibattito pubblico. Ogni cittadino europeo acquista 19 chili di vestiti l’anno, producendo 7 milioni di tonnellate di rifiuti. Il 70% di questi finisce in discarica o negli inceneritori, e solo una minima parte trova una seconda vita attraverso il riciclo. La fast fashion, con i suoi capi a basso costo e durata minima, ha reso normale ciò che un tempo era eccezione: buttare un vestito dopo pochi mesi di utilizzo.
L’Italia ha una responsabilità doppia: da un lato ospita distretti tessili tra i più avanzati al mondo, dall’altro è tra i mercati di riferimento per i brand globali che sfornano collezioni a ritmo frenetico. Il World Cleanup Day mette il dito nella piaga con la campagna “Waste Less When You Dress”: ridurre il consumo di fast fashion significa non solo abbattere le montagne di rifiuti tessili, ma anche tagliare l’impatto ambientale di una filiera che divora acqua e produce emissioni.
A Ponticelli, quartiere popolare di Napoli, la campagna è partita con una sfilata di borse realizzate da abiti recuperati. Un gesto simbolico, certo, ma che mostra come la sostenibilità non sia un lusso da boutique: è questione di ripensare l’intero ciclo del consumo, dal design al riuso. L’alternativa non è tra vestirsi o salvare il pianeta: è decidere se continuare a sostenere un modello che trasforma il pianeta stesso in una discarica.
Quando i cittadini fanno rete meglio delle istituzioni
Il World Cleanup Day è nato in Estonia, un Paese che nel 2008 decise di mobilitare i cittadini per ripulire il territorio in una sola giornata. Da lì si è trasformato in un movimento globale che oggi coinvolge 191 Paesi. Il segreto non sta nei grandi finanziamenti, ma nella capacità di costruire reti dal basso. In Italia, la macchina organizzativa si regge soprattutto sul volontariato e su associazioni come Retake e Legambiente. È la prova che la cittadinanza attiva, se ben coordinata, riesce a produrre risultati che spesso la burocrazia non ottiene.
C’è un rovescio della medaglia, però: il rischio di trasformare i cittadini in supplenti di istituzioni assenti. Quando i volontari raccolgono sacchi di rifiuti lungo il Tevere o sulle spiagge di Palermo, stanno colmando un vuoto. Il gesto ha un valore simbolico e pratico, ma da solo non basta a risolvere problemi cronici come la mancanza di impianti adeguati o il business del traffico illecito. La forza del movimento sta nel mettere pressione alle istituzioni, non nel sostituirle.
Eppure, la spinta dal basso produce effetti concreti: la visibilità mediatica del World Cleanup Day crea un’agenda che costringe enti locali e nazionali a prendere posizione. In Estonia la giornata è entrata nelle politiche pubbliche, in altri Paesi ha dato vita a collaborazioni strutturate con aziende private. In Italia siamo ancora a metà del guado: la mobilitazione c’è, ma fatica a trasformarsi in cambiamento strutturale.