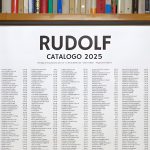Ogni cittadino europeo getta via, in media, 132 kg di cibo ogni anno. Un dato che, moltiplicato per la popolazione dell’Unione, si traduce in circa 59 milioni di tonnellate di alimenti sprecati. Si tratta di un fenomeno che ha un impatto profondo non solo sotto il profilo etico, ma anche economico e ambientale. L’Agenzia Europea dell’Ambiente stima che ogni anno lo spreco alimentare costi all’Unione circa 132 miliardi di euro, generando allo stesso tempo emissioni equivalenti al 16% dell’intero sistema agroalimentare.
L’attenzione al tema è cresciuta negli ultimi anni, ma i numeri restano elevati e confermano che gli strumenti finora adottati sono ancora parzialmente inefficaci. Nonostante campagne di sensibilizzazione, progetti locali e strategie su scala nazionale ed europea, la riduzione dello spreco alimentare è ancora ben lontana dagli obiettivi fissati. Eppure, ridurre queste perdite lungo la filiera alimentare rappresenta una delle azioni più rapide e meno costose per ridurre l’impronta ambientale del nostro sistema alimentare.
Nel 2024, la Commissione europea ha proposto due obiettivi vincolanti per tutti gli Stati membri: una riduzione del 10% degli sprechi alimentari nella fase di produzione e trasformazione, e una riduzione del 30% nel commercio al dettaglio e a livello domestico, da raggiungere entro il 2030. Un impegno che richiederà interventi mirati e strutturali, capaci di incidere su ogni anello della catena.
Dove si spreca lungo la filiera
Lo spreco alimentare è un problema diffuso e trasversale. Si verifica in ogni fase della filiera, dalla produzione primaria alla trasformazione industriale, dalla distribuzione fino al consumo domestico. Non si tratta quindi di un comportamento individuale isolato, ma di una criticità sistemica che riflette inefficienze logistiche, dinamiche di mercato distorte, standard commerciali rigidi e, non ultimo, modelli culturali consolidati.
Secondo i dati dell’Eurostat e dell’Agenzia Europea dell’Ambiente, una quota significativa dello spreco si concentra nella fase del consumo domestico: oltre la metà degli alimenti buttati proviene direttamente dalle case dei cittadini. Tuttavia, anche la fase di produzione e trasformazione genera volumi consistenti di scarti: prodotti che non rispettano criteri estetici o di calibro, partite eccedenti rispetto alla domanda o danneggiate durante la raccolta, sottoprodotti che non trovano valorizzazione.
Le cause principali dello spreco variano a seconda del segmento della filiera. In ambito agricolo, ad esempio, pesano le difficoltà di previsione della domanda, i vincoli imposti dalla grande distribuzione e la mancanza di infrastrutture per la conservazione. Nell’industria alimentare, invece, le perdite sono spesso legate a difetti di processo, a scorte mal gestite o alla mancanza di sbocchi alternativi per i prodotti invenduti. Nella ristorazione, infine, lo spreco è spesso associato a porzioni eccessive, menù poco flessibili e una pianificazione inefficace.
Nonostante la crescente attenzione istituzionale, il problema rimane difficile da affrontare. Il motivo principale risiede nella frammentazione delle responsabilità: ciascun attore della filiera agisce in base a logiche autonome, spesso scollegate dalle esigenze di sostenibilità complessiva. Inoltre, le attuali misure di monitoraggio e rendicontazione del cibo sprecato sono ancora poco omogenee tra i diversi Stati membri, rendendo complessa una valutazione comparativa efficace.
Tuttavia, il nuovo quadro normativo europeo rappresenta un passaggio decisivo. Se approvati, gli obiettivi vincolanti contribuiranno a rafforzare l’integrazione tra politiche ambientali, agricole e sociali, ponendo lo spreco alimentare al centro delle strategie per la neutralità climatica, la sicurezza alimentare e la transizione ecologica.
I costi (non solo economici) del cibo buttato
Dietro ogni alimento gettato si nasconde un ciclo produttivo complesso, fatto di risorse naturali impiegate, energia consumata, manodopera coinvolta, trasporti organizzati, emissioni prodotte. E il prezzo di questo spreco non si misura solo in euro: riguarda anche la salute dei suoli, la disponibilità di acqua dolce, la stabilità climatica e la tutela della biodiversità.
La produzione di cibo assorbe circa il 70% dell’acqua dolce disponibile, contribuisce al 25% delle emissioni globali di gas serra, occupa il 40% della superficie terrestre libera da ghiacci e comporta l’uso massiccio di fertilizzanti e pesticidi. Quando il cibo viene sprecato, anche queste risorse sono utilizzate invano, amplificando l’insostenibilità dell’intero sistema.
C’è poi il nodo della biodiversità. Le coltivazioni intensive, spesso orientate a soddisfare una domanda eccessiva o mal calibrata, sono tra i principali fattori di degrado degli ecosistemi naturali. La deforestazione, la frammentazione degli habitat, la contaminazione delle acque e l’erosione del suolo sono spesso legate a modelli agricoli non sostenibili, incentivati da una produzione destinata in parte a non essere mai consumata. In altre parole, lo spreco alimentare aggrava inutilmente le pressioni sulla natura, mettendo a rischio la sopravvivenza di numerose specie e la resilienza dei territori.
Infine, lo spreco alimentare ha anche una rilevanza sociale. In un’Europa in cui milioni di persone vivono in condizioni di insicurezza alimentare — secondo Eurostat, nel 2023 quasi il 9% della popolazione dell’Ue non poteva permettersi un pasto proteico ogni due giorni — il fatto che una quantità enorme di cibo venga buttata rappresenta una contraddizione morale ed etica difficile da ignorare.
Quando l’innovazione riduce gli sprechi
Nel tentativo di invertire la rotta dello spreco alimentare, la tecnologia sta emergendo come alleato strategico. Le startup dell’agritech e del foodtech, sostenute da università, incubatori e fondi d’investimento sensibili alla sostenibilità, stanno sviluppando soluzioni capaci di intercettare il problema prima che si manifesti, automatizzando il monitoraggio delle scorte, prevedendo la domanda con maggiore accuratezza e facilitando il recupero del cibo prossimo alla scadenza.
Un esempio concreto arriva dalla nona edizione di Fare impresa in Italia, il convegno annuale promosso dall’Università Lumsa che dedica sempre maggiore attenzione alle imprese a impatto sociale e ambientale. Tra i protagonisti, Chiara Cavallo, co-founder della startup Alfred, ha raccontato come la tecnologia possa trasformare una voce di costo invisibile in un’opportunità. Alfred, ispirata all’iconico maggiordomo di Batman, è una piattaforma che aiuta supermercati e negozi a gestire e ottimizzare le scadenze dei prodotti alimentari, evitando che vengano buttati.
Il valore di questo approccio è triplice, come ha spiegato Cavallo: economico, perché riduce le perdite per le aziende; ambientale, perché evita la produzione di rifiuti e le emissioni connesse; umano, perché consente agli operatori di lavorare meglio, affidando alla tecnologia le operazioni più ripetitive e lasciando spazio alla relazione con il cliente e alla gestione consapevole degli spazi di vendita.